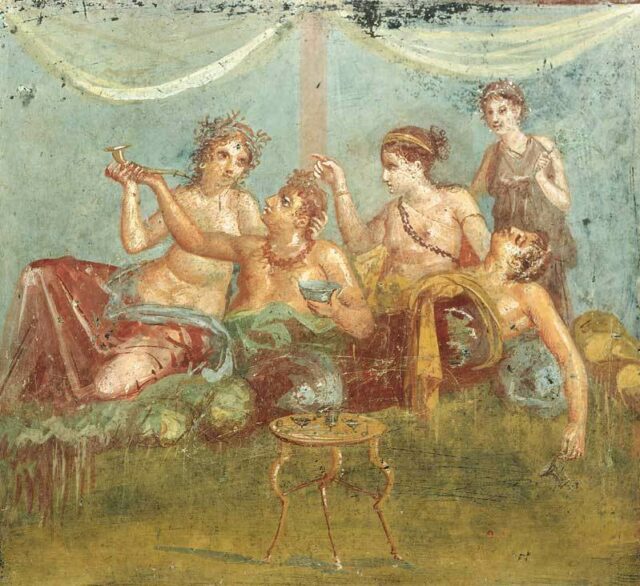Come venivano allevati pecore, capre e maiali nell’antica Pompei? Come venivano sfruttate le risorse di acqua dolce e marina? E i cereali e i legumi, come venivano coltivati? A svelare i segreti dell’alimentazione che veniva seguita dai pompeiani duemila anni fa è un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature, guidato da Silvia Soncin del Department of Environmental Biology and Mediterranean bioArchaeological Research Advances Centre della Sapienza Università di Roma.
Lo studio dei diversi prodotti che costituivano la base della dieta degli abitanti di Pompei insieme alle tecniche di coltivazione è stato oggetto di un’analisi realizzata in collaborazione tra l’Università La Sapienza di Roma, il Dipartimento di Archeologia dell’Università di York, il Laboratorio di Ricerca Applicata “Annamaria Ciarallo” del Parco di Pompei e il laboratorio DistaBiF dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Questo studio svela dettagli inediti sulla dieta degli animali di allevamento al tempo dei Romani, offrendo una fotografia dell’alimentazione di quasi duemila anni fa.
La ricerca si è avvalsa di una tecnica avanzata – l’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto – su diverse piante (cereali, legumi, frutti) e animali (erbivori, suini, polli, pesci), per costruire una baseline isotopica locale per poter interpretare correttamente le analisi sulla dieta umana a Pompei. La baseline isotopica locale è un riferimento chimico che descrive i valori naturali di isotopi (che – per semplificare – sono delle “tracce” chimiche che si accumulano nei tessuti di piante e animali in base a ciò che mangiano e al loro ambiente) presenti nelle piante e negli animali di un luogo specifico in un certo periodo. Serve per capire cosa mangiavano le persone, perché i valori isotopici cambiano in base al territorio, al clima e alle coltivazioni.
Analizzando le ossa degli animali ritrovati a Pompei gli scienziati sono riusciti a ricostruire la loro alimentazione. I risultati hanno mostrato una straordinaria diversità nelle pratiche di allevamento: non tutti gli animali venivano nutriti allo stesso modo e la loro dieta variava significativamente a seconda della specie.
I suini
I suini mostrano una dieta molto varia e diversa dagli erbivori: lo studio suggerisce che venivano alimentati in modo diversificato, probabilmente con scarti alimentari e rifiuti urbani. Il loro “profilo isotopico” indica un’alimentazione più onnivora e meno legata al pascolo, compatibile con un allevamento in contesti semi-domestici o urbani, dove erano probabilmente nutriti con quello che trovavano o veniva dato loro.
Gli erbivori: pecore, capre e bovini
Pecore, capre e bovini presentano valori isotopici tipici di erbivori che si nutrono di erba e foglie. Questi animali erano probabilmente allevati all’aperto su pascoli e terreni coltivati. La variabilità isotopica riflette possibili differenze di ambiente e alimentazione stagionale, come pascolo libero o foraggi raccolti.
Altri animali (polli, pesci)
I polli mostrano chiari segnali di consumo di piante come il miglio, probabilmente coltivate o reperite nelle aree circostanti. I pesci riflettono diverse tecniche di pesca in ambienti sia marini che di acqua dolce. Non solo animali: uno sguardo sull’agricoltura Oltre agli animali lo studio ha analizzato anche i resti vegetali, rivelando che i Romani utilizzavano una vasta gamma di tecniche di coltivazione. La variabilità isotopica nei cereali e nei legumi indica l’uso di diversi metodi di irrigazione, concimazione e rotazione delle colture. Questo suggerisce un’agricoltura molto più sofisticata e diversificata di quanto si potesse pensare, capace di adattarsi a diversi tipi di piante e terreni.
La complessità di “decifrare” l’alimentazione umana
Oltre ai risultati ottenuti, la ricerca ha messo in luce anche i limiti di questo tipo di indagine: mentre, infatti, l’analisi isotopica è eccellente per capire la dieta dei singoli animali, diventa più difficile ricostruire la complessità della dieta umana. L’alimentazione dei Romani era così varia che le “tracce” isotopiche si mescolano, rendendo complicato distinguere esattamente cosa mangiasse un singolo individuo.